La manomissione delle parole
“La manomissione delle parole” non è un romanzo e non è nemmeno un saggio.
“È stato un gioco. Un gioco personalissimo e, in qualche misura, inevitabilmente arbitrario, di cui parte essenziale sono stati i libri degli altri. Ho giocato a smontare e rimontare le parole come certi bambini fanno con i giocattoli. Con lo stesso spirito: per vedere cosa c’è dentro, per capire come funzionano, per sperimentarne usi diversi. Senza seguire le istruzioni.”
Così dice del suo libro l’autore Gianrico Carofiglio. Lo definisce un gioco, un gioco che comincia direttamente nel titolo. Il termine ‘manomissione’ è interessante, perché ha due significati molto diversi tra loro. Indica alterazione, danneggiamento, violazione e questa è l’accezione negativa. Nel diritto romano, si chiamava manomissione (lat. manumissio) la cerimonia con la quale uno schiavo veniva affrancato dal padrone ed è quindi sinonimo di liberazione, riscatto, emancipazione. Una valenza del tutto positiva. Due azioni che si compiono con l’utilizzo delle mani e che descrivono situazioni opposte, soprattutto nelle intenzioni.
La stessa cosa può succedere nell’utilizzo delle parole: si alterano e si danneggiano se non si conoscono, mentre si rendono libere quando si utilizzano nel loro vero significato.
“Le parole sono atti, dei quali è necessario fronteggiare le conseguenze”.
Parlare è compiere una azione. Comunicare è compiere una azione. La cura delle parole e la conoscenza approfondita del loro significato sono le condizioni indispensabili
“per dare un senso alle parole stesse, per cercare di dare un senso alle cose, ai rapporti fra le persone, alla politica intesa come categoria nobile dell’agire collettivo”.
Carofiglio decide di ‘giocare’ con alcune parole “scelte in modo personale e inevitabilmente arbitrario.” 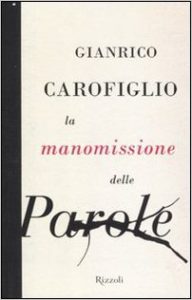
Sono cinque termini che fanno parte del linguaggio comune e che sono stati, e sono tuttora, particolarmente svuotati del loro significato.
La prima parola maltrattata è vergogna; la radice del latino verecundia è la stessa di vereor che significa ‘rispettare’. Non è un caso che nel greco antico provare vergogna e rispettare fossero due accezioni dello stesso verbo aidéomai.
La vergogna è un sentimento che possiamo provare solo in riferimento a noi stessi ed è collegato alla perdita dell’autostima, prima ancora della stima degli altri. È un sentimento individuale e sociale allo stesso tempo, un sentimento destabilizzante che nasce dalla consapevolezza della violazione di un codice etico e morale individuale, prima ancora che collettivo.
Giustizia è la seconda parola. Si presta a innumerevoli interpretazioni e indica il principio di uguaglianza sociale di tutti i cittadini davanti alla legge, l’equa ripartizione dei beni, l’abolizione di qualsiasi forma di sfruttamento. Fino a ‘Una teoria della giustizia’ di Rawls che definisce
“la giustizia come il primo requisito delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero”;
la giustizia diventa sinonimo di equità, con uno spostamento semantico significativo. Tutto ciò che è giusto è equo e, viceversa, tutto ciò che è equo non può non essere giusto.
Ribellione è un’altra parola che merita di essere smontata e rimontata, per capirne l’importanza e per rendersi conto di quanto spesso venga utilizzata in modo impreciso. Quando si pensa alla ribellione, ci si immagina subito qualcosa di fisico, di violento, di brutale, al di fuori della legge. Se ci si ferma a riflettere con più calma, salta subito all’occhio la parzialità di questa interpretazione. Un nome? Gandhi. Il suo atto di ribellione è stato tutto fuorché fisico, violento e brutale.
“George Steiner e José Saramago hanno scelto No come prima parola di un ideale lessico necessario”. In effetti, dire No è un atto di ribellione molto potente e per nulla violento. È una ribellione del pensiero, il punto di partenza di un cambiamento che nasce dal rifiuto di uno stato di fatto, di una condizione nella quale non ci si riconosce più, se già in essere, o nella quale non ci si vuole ritrovare.
“La Bellezza non è dunque un ornamento. È una forma di salvezza e insieme una categoria morale. È il sintomo, o forse, più precisamente, il farsi visibile e concreto del bene morale.”
Nella cultura greca antica, il termine kalòs (gr. καλὸς), “bello” si riferisce non solo ciò che lo è da un punto di vista estetico, percepibile, ma indica soprattutto una accezione di bello connesso a un comportamento morale, agathòs “buono” (gr. ἀγαθός). Bellezza e bontà sono talmente legate da diventare inscindibili nel concetto di kalokagathìa (gr. καλοκαγαθία), che deriva dalla fusione delle due parole e che indica l’ideale di perfezione fisica e morale da perseguire sempre prima di qualsiasi altra cosa. Ancora oggi, difficilmente, ciò che è bello non è anche etico, e viceversa.
L’ultima parola che Garofiglio ci racconta è Scelta, “diversa da tutte quelle che abbiamo esaminato finora. Per rendersene conto basta aprire il vocabolario e constatare che essa ha numerosi sinonimi, ma nessun contrario”.
La capacità di scegliere e la possibilità di farlo sono la discriminante tra schiavitù e libertà.
“Scelta è il contrario di rinuncia, di conformismo e di vigliaccheria.
Scelta è il contrario di vergogna.
Scelta è il contrario di indifferenza.”
Scegliere è un atto di coraggio. È una assunzione di responsabilità attraverso la quale definiamo il nostro futuro e, in parte, quello degli altri.
Queste cinque parole sono tutte apparentemente indipendenti le une dalle altre.
Se ci pensiamo bene, non è del tutto vero. Proviamo vergogna, ad esempio, quando manchiamo di rispetto a qualcuno. Quasi sempre mancare di rispetto significa far venir meno la giustizia nei confronti di quella persona. La giustizia può essere ripristinata con un atto di ribellione, che non implica necessariamente una rottura violenta, ma può essere semplicemente dire no. Ribellarsi a ciò che è ingiusto è il punto di partenza per cercare di recuperare ciò che è etico e morale. Etica e morale sono quasi sempre inscindibili dalla bellezza. Tutto questo può e deve essere il risultato di una scelta. Provare vergogna è una scelta, perseguire la giustizia è una scelta, ribellarsi a tutto ciò che non è etico è una scelta, difendere la bellezza è una scelta.
“(…) perché già solo chiamare le cose con il loro nome è un atto rivoluzionario”.
È provare vergogna per un utilizzo improprio delle parole che non rende giustizia né a loro né tanto meno a noi. È un atto di ribellione nei confronti del degrado e della strumentalizzazione, finalizzato al recupero della bellezza delle parole e delle loro storie. Chiamare le cose con il loro nome è una scelta di responsabilità, di civiltà, di democrazia.
G. Carofiglio, La manomissione delle parole, Rizzoli, 2010, pp. 187, € 9.00






