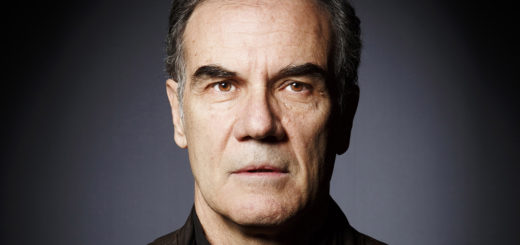Essere senza destino
“Essere senza destino” è un racconto autobiografico di Imre Kertész.
Gyurka non ha ancora compiuto quindici anni quando una sera è costretto a salutare il padre chiamato per l’Arbeitsdienst, il periodo di lavoro obbligatorio. Poco dopo lui stesso viene arruolato per lavorare alla Shell. Prelevato alla fermata dell’autobus, all’improvviso, secondo un copione che sembra assolutamente naturale, è costretto a partire per la Germania. È questo l’inizio della difficile esperienza da deportato prima ad Auschwitz e poi a Buchenwald, dalla quale uscirà definitivamente trasformato e mai più capace di essere come era prima.
La trama è quindi piuttosto semplice, una storia di deportazione difficile e drammatica come quella di tutte le persone che sono state costrette a passare una parte della loro vita in un campo di concentramento.
Quello che mi ha colpito molto, moltissimo, è il modo con cui l’autore ci racconta i fatti. Lo stile è essenziale. Frasi molto brevi di pura cronaca. I fatti vengono raccontati come se fosse un freddo resoconto, senza connotazioni altre rispetto alla mera descrizione di come è andata realmente. Il lettore viene messo a conoscenza dei fatti che il ragazzo racconta e descrive come “naturali”, quasi logici; essere senza destino è normale. Emblematico a questo proposito il dialogo che Gyurka ha con un giornalista che vorrebbe lui raccontasse la sua storia di sopravvissuto:
“«Giovanotto (…) perché dici sempre che è naturale, e soprattutto per cose che non lo sono affatto!» Gli dissi che nel campo di concentramento tutto questo era naturale. «Sì, certo», mi rispose, «là è vero, ma…» e qui si bloccò, esitò un attimo, «ma … voglio dire, il campo di concentramento in sé non è naturale!» finalmente aveva azzeccato su per giù la parola giusta e, infatti, io non replicai, perché un po’ alla volta cominciavo a capire: di certe cose non si può discutere con estranei, con gente ignara, in un certo senso con dei bambini, diciamo così”
In questo scambio di battute l’atteggiamento del protagonista-autore, a mio parere, rende bene il senso della devastazione che una esperienza del genere produce in maniera irreversibile in chi l’ha vissuta. Allo stesso tempo però è emblematico il distacco critico con cui essa stessa viene raccontata a chi, non avendola vissuta, non potrà mai capire davvero fino in fondo il senso, o non senso, della realtà del mondo concentrazionario.
La realtà dei campi e le dinamiche relazionali che governano la vita al loro interno sono di fatto “naturali” in quel contesto. Kertész sostiene che l’Olocausto è ovunque e lo sostiene in virtù del fatto che ciò che è successo a lui avrebbe potuto accadere a chiunque con la stessa apparente naturalezza. Non c’è bisogno di esprimere un giudizio in merito alla deportazione. È un fatto che deve essere descritto nella sua crudezza e durezza, perché non c’è davvero bisogno di dire che è stata una tragedia senza senso e del tutto inconcepibile. Questo il lettore lo deve sapere da solo. Il metodo artistico per il suo romanzo doveva essere dichiarativo e ordinario.
Le vittime del Male non avrebbero potuto esprimersi che con un linguaggio esso stesso dichiarativo e ordinario.
Non serviva altro, come dimostra benissimo l’inizio del romanzo:
«Oggi non sono andato a scuola. O meglio, ci sono andato, ma solo per farmi esonerare dal nostro professore. Gli ho portato la lettera di mio padre, in cui richiede il mio esonero per motivi famigliari. Il professore ha chiesto quali fossero questi motivi famigliari. Io gli ho risposto che mio padre è stato chiamato al periodo di lavoro obbligatorio; a quel punto lui non ha più fatto obiezioni».
Questo romanzo autobiografico è valso a Kertész il premio Nobel per la letteratura nel 2002.
I. Kertész, Essere senza destino, Feltrinelli, 2014, pp. 223, € 9.50